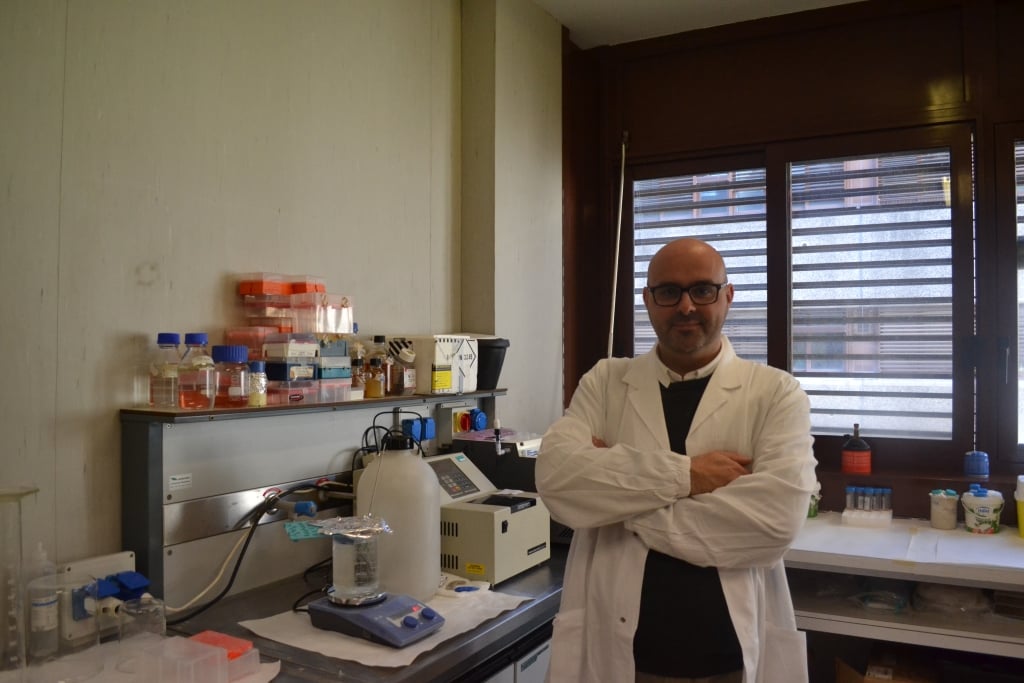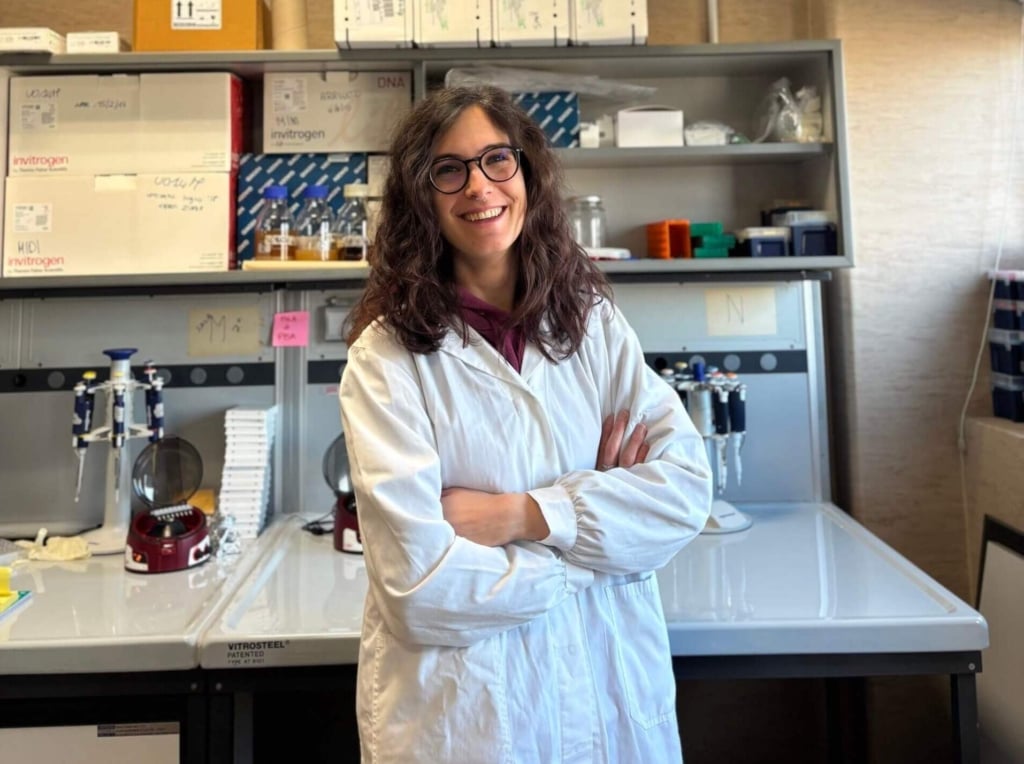L’autofagia (dal greco «mangiare se stessi») è un meccanismo fondamentale per le cellule del nostro organismo, la cui scoperta è valsa il Nobel per la Medicina del 2016 al biologo giapponese Yoshinori Oshumi. Attraverso l’autofagia, le nostre cellule si «auto-riciclano» e si rigenerano, ovvero distruggono le componenti danneggiate o inutili e producono energia e proteine per il rinnovamento cellulare. L’autofagia ha però anche un lato oscuro che si può manifestare nello sviluppo della resistenza ai tumori. Grazie al supporto del progetto SAM-Salute al Maschile di Fondazione Umberto Veronesi Francesco Marampon, medico radiologo e ricercatore dell’Università di Roma La Sapienza, cercherà di fare luce sul coinvolgimento di questo meccanismo nel trattamento del tumore della prostata.
Francesco, dicci di più sul tuo progetto di ricerca.
«L’utilizzo della radioterapia ha rivoluzionato la cura del cancro alla prostata, tuttavia alcuni pazienti non rispondono al trattamento, con conseguenti recidive di malattia e metastasi. Numerosi studi suggeriscono un ruolo chiave del processo autofagico nello sviluppo della resistenza alla radioterapia: nelle fasi iniziali della cura, l’autofagia potrebbe promuovere la sopravvivenza delle cellule tumorali e la resistenza alle terapie. Il mio progetto vuole analizzare e chiarire in che modo il processo autofagico regola e sostiene la radioresistenza delle cellule tumorali».
Una volta chiariti i meccanismi della radioresistenza, si potrebbero quindi sviluppare farmaci in grado di aggirarla?
«Esattamente. Una volta identificate, le molecole responsabili della radioresistenza potranno essere utilizzate come bersagli molecolari per lo sviluppo di nuovi farmaci capaci di rendere le cellule tumorali più sensibili all’azione della radioterapia».
Sei un medico ma fai il ricercatore a tempo pieno. Perché hai scelto questa strada?
«Già durante la scuola superiore ero affascinato dalla biologia e questa passione è cresciuta durante gli anni di studio a Medicina. Ricordo perfettamente il momento in cui decisi che la ricerca sarebbe stata la mia strada. Stavo studiando i meccanismi molecolari responsabili della crescita incontrollata delle cellule del rabdomiosarcoma, un tumore pediatrico molto grave. Avevo ipotizzato il coinvolgimento di una specifica proteina e l’analisi successiva mi diede ragione. Ricordo con grande emozione quel momento, celebrato dalla luce rossa della camera oscura in cui stavo sviluppando la lastra che confermava la mia ipotesi».
Sei mai stato all’estero a fare un’esperienza di ricerca?
«Sì: ho lavorato presso il Kimmel Cancer Center di Philadelphia: da una parte sentivo la necessità di imparare nuove metodiche di ricerca e dall’altra volevo verificare in prima persona come fosse lavorare in un Paese che in quel tempo investiva moltissime delle risorse disponibili per la ricerca scientifica. È stato esaltante avere avuto la possibilità di lavorare in un ambiente scientificamente competitivo senza avere restrizioni in termini di risorse».
C’è invece un momento della tua vita da ricercatore che vorresti cancellare?
«Il 6 aprile 2009, il giorno del terremoto che distrusse L’Aquila. Ero riuscito da poco a creare delle nuove linee cellulari per i miei esperimenti e stavo ottenendo dei buoni risultati, quando il terremoto che colpì la città distrusse il laboratorio. Mi sarei aspettato tutto, ma non questo. In onore di chi perse molto più che una linea cellulare e dell’Università dell’Aquila, verso la quale ho sempre nutrito grande affetto, decisi che anch’io avrei riscostruito quanto perso».
La ricerca è una sfida continua. Ti piace questo aspetto del tuo lavoro?
«Assolutamente sì. Chi sceglie di fare ricerca su una malattia, non conosce le caratteristiche del proprio “rivale”. Lo sfidante è un avversario passivo e questo rende la competizione ancor più impegnativa e stimolante. La ricerca è anche uno dei pochi settori in cui anche il risultato negativo ha un valore inestimabile. Normalmente non c’è un premio per la squadra perdente. Nella ricerca, invece, un dato contrario a quello atteso e apparentemente negativo può rappresentare la chiave di volta per importanti scoperte».
C’è invece qualcosa che non ti piace del mondo della ricerca?
«La saccente ignoranza di chi ritiene di essere il migliore. L’universo è in costante evoluzione e non esista nulla che non possa essere migliorato, tanto più l’essere umano».
Se ti dico scienza e ricerca, cosa ti viene in mente?
«Libertà e crescita. Libertà di pensiero e di azione per la crescita del bene collettivo».
Quali sono secondo te i campi di ricerca più promettenti per i prossimi decenni?
«Se dovessi scommettere su un filone di ricerca particolarmente innovativo, sceglierei la “targeted therapy” dinamica, ovvero la caratterizzazione della malattia e il monitoraggio costante della sua evoluzione tramite l’analisi della composizione molecolare. Inoltre, sono convinto dell’importanza della diagnosi precoce e per questo penso sia importante spingere la ricerca verso l’identificazione di nuovi biomarcatori rilevabili ancor prima che la malattia si manifesti clinicamente».
Hai due figlie gemelle di cinque anni. Se un giorno ti dicessero che vogliono fare le ricercatrici, cosa diresti loro?
«Che ognuno è l’artefice della propria fortuna. Spiegherei loro che è un lavoro complesso e che le difficoltà sono molte, specialmente sul piano economico. Ma gli racconterei anche della bellezza della scoperta, della pienezza e della soddisfazione del sapere. Senza guardarle negli occhi però: non vorrei rischiare di contagiarle né con il mio entusiasmo né tanto meno con la delusione».
Un ricordo a te caro di quando eri bambino?
«Spesso d’inverno, magari durante un temporale, andava via la luce e per non restare al buio si accendevano le candele che rendevano l’atmosfera ancor più magica. Ero fiero, come lo sono ora, della mia famiglia senza la quale non sarei riuscito a realizzare tutto quello che ho fatto fino ad ora».
Hai mai fatto qualche “pazzia”?
«Tornare in Italia, acquistare casa e mettere su famiglia».